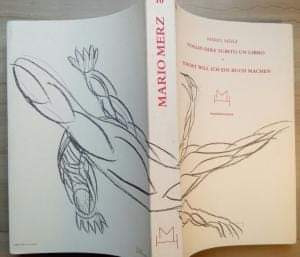Si sa che non sono mai, le mie, note critiche, ma appunti di letture, avvisi ai naviganti e che parlo di ciò che mi crea interesse e compone, unitariamente, un percorso metodologico del mio essere lettore. A volte mi prendo la briga di segnalarvi libri che magari non sono novità assolute ma che potrebbero essere sfuggiti al vostro attentissimo occhio di lettori. E lo faccio con l’accortezza, la cura, la dovizia e la sfrontatezza che dovrebbe essere prevista per ogni buona intenzione, un viatico mio che mi prendo la gioia di trasferirvi, senza altra ragione se non quella dell’informazione conoscitiva. E poi ci metto dentro cose mie che, col libro di cui parlo, forse non c’entrano. Forse. Qualcuno mi ha fatto notare che le mie segnalazioni son poco gaye, come se ci fosse la necessità di parlar solo di quello, come se soltanto di quello io dovessi poter parlare.
Chiedo venia e così vi parlo di Roberto Paterlini che è nato e vive in provincia di Brescia nel 1981. Nel 2006 ha vinto il Sonar Script Festival con una sceneggiatura dal titolo 23 Anni e nel 2007 ha pubblicato il suo primo romanzo Il ventiquattrenne più vecchio del mondo.
Nel 2012 ha vinto il premio letterario “La Giara” con questo suo secondo romanzo, Cani randagi (Edizioni Rai.Eri, 2012).
“Era incastrata tra due cassetti, potrebbe essere lì da anni. Ci pensi?” disse Federico, con gli occhi che gli volevano uscire dalle orbite, luccicanti ed entusiasti come se fossero davvero stati di fronte a un tesoro.
Catania 1987, riportava la scritta a biro appiccicata al lato dell’audiocassetta ingiallita e staccata ai bordi.
“Perché non c’è un cazzo di libro di storia, o di documentario, o di film, o di festività nazionale che ricordi e commemori anche i poveri froci che sono stati privati della loro libertà?“.
Ci son storie qui dentro, tenute saldate con forte impatto narrativo – anche se non esattamente sulla mia stessa lunghezza d’onda dal punto di vista della scrittura, ma questo sarà un mio limite – condotte con fermezza e con una scrittura concentrata sui dettagli che appassiona puntando bene l’attenzione sull’evolversi della percezione dell’omosessualità in quasi un secolo di storia, ma anche parlandoci di nodi irrisolti, di silenzi, difficoltà e pregiudizi.
Parrebbe essere un libro “militante” ma questo non ne sminuisce la realtà di romanzo, mostrandone invece la solidità, perché in Italia, dove il tema dell’eguaglianza di ogni forma d’amore è ancora una lontana aspirazione, l’omosessualità è ancora un tema di grande impegno civile oltre che di straordinaria forza narrativa.
Cani randagi ha dunque vinto la prima edizione del Premio Rai “La Giara”, la stessa Rai, che solo qualche anno fa censurava le timide evoluzioni amorose dei Segreti di Brokeback Mountain, premia ed è pure editore di un romanzo a tematica omosessuale. Gioie e incongruenze, associazioni e dissociazioni. Editori e premianti. Tutto in un solo colpo. Ebbravi.
Come sappiamo si rimpiange, si rimorde, si odia per tutto quello che si è fatto o non si è fatto in amore. Storie che si incastonano anche nel centro delle nostre generazioni, si ficcano a metà tra le generazioni, si incastonano diamantine e bellissime. A volte la bellezza, per quanto casuale e ingiusta, qui viene narrata proprio come se avesse, per davvero, ogni diritto di essere ambita e desiderata, e guadagnasse il suo sacrosanto primato anche sul marcio pensiero di questa società o il cattivo carattere di chi, sul serio, può pensare che questi “si amano davvero, lottando però contro la stessa e misera paura che amare una sola persona costituisca una prigionia” un elemento di disturbo. Il gay, come si sa, non può amare. Esso, non egli, è solo buso.
Ed è come se, invece, qui i personaggi cercassero di ritrovarsi, ad amarsi come a rintracciare le loro anime sperdute e la loro indipendenza tra braccia spesso diverse e sconosciute, fino ad incontrare il male del secolo – l’AIDS che non è una punizione per gli omosessuali – fino decisamente a lanciare uno sguardo mozzafiato su un nembo di tristezza agghiacciante: la paura d’amare ed essere riamati. E tutto questo in una scrittura di luce bianca e nera, che questo ansito amoroso lo narra con forza.
L’espediente narrativo iniziale è l’audiocassetta ritrovata che contiene un’intervista in cui un anziano racconta quanto accadde a Catania alla fine degli anni Trenta, quando, ragazzo, veniva condannato al confino perché omosessuale o, come si diceva in quegli anni in Sicilia, un arrusu, che possiamo tradurre con passivo, busone, frocia, femminiello, checca fino ad esaurimento dei vocaboli dialettali. Uno è il masculo e l’altro solo l’arruso: poiché ficcando l’onore del maschio è salvo, la finocchia al buio è il nulla assoluto, la mancanza di dignità, il non esistente, è un buco da riempire, per svuotarsi.
In tutto il romanzo, assaggi di amarezza, che colano sempre, fino quasi a definire che c’è sempre differenza fra chi è “attivo”, e più “maschio”, e chi è “passivo”, e più “femmina”, una mentalità dura a morire, anche fra i gay stessi, non dimentichiamolo. Ma qui vado oltre il seminato del libro, che comunque queste domande le pone. A modo suo.
Nell’Italia fascista la testimonianza di una forma di resistenza che gli omosessuali sono stati in grado di esprimere anche nei momenti di maggiore repressione.
Ci si chiede, ad un certo punto, per quale motivo uno che ha 22 anni, un diploma e una quasi laurea, che è gay, non abbia mai sentito parlare del confino di tanti omosessuali alla fine degli anni Trenta, in Italia. Eppure questo fa parte della Storia e anche di questa storia. Ma è parte anche della nostra realtà di viventi il non conoscere, il non sapere, il volere atteggiarsi unicamente a gay che passivamente vivono, questo sì, la loro quotidianità tra il bel vestire, la cantante pop di turno e l’accozzaglia di luoghi comuni sull’età e la bellezza fisica (ah, dimenticavo che oggi va di moda anche la barba). Questo siamo e questo ci meritiamo, niente di più. Istantanee di vita, niente di più: non deve essere perfetta per nulla questa nostra vita se, tanto, alla fine tutti si muore – tra l’amore di oggi e quello di ieri – con l’amore che va bene o che non va bene, come deve essere nella vera natura dell’amore, del nostro amore e anche di questi amori di carta straccia.
Mettendo insieme il suo amore per la letteratura e la sua capacità di trasformare in storie che emozionano e appassionano, Paterlini scrive un romanzo che è anche un buon appello alla memoria civile e che esprime bene il bisogno degli omosessuali, come di tutti del resto, di avere una storia che parli di loro, che rievochi i torti e le strategie di resistenza che siamo stati in grado di elaborare. Riesce leggermente a condurci per mano attraverso problematiche e tematiche come l’amore, l’ossessione, la persecuzione, la malattia che, vorrei rammentare, sono universali e non legate specificatamente al mondo omosessuale.
Penso che molti giovani, di paese o di città, che si sentono diversi, sbagliati (ancora ci sono questi spettacoli di solitudine, anche nelle grandi città, non dimentichiamolo mai, questi diciassettenni che scrivono lettere a LaRepubblica e ricevono le belle risposte di chi le risposte le ha in tasca, di chi sa cosa rispondere, di chi sa cosa dire per consolare, come a significare: io so come va, come andrà e adesso te lo spiego) troveranno un libro che verrà a concretizzare loro un mondo, un loro mondo, con le loro stesso risposte che, a quell’età, stentano a venire e che nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di dirti. Troveranno un mondo pieno di perplessità e pieno di persone uguali a loro.
©Bo Summer’s 2013 tutti i diritti riservatiriproduzione vietata