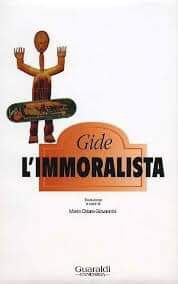Le traduzioni, come i traduttori, sono destinate a invecchiare. Il continuo mutare degli orizzonti culturali rende la ritraduzione dei classici non solo auspicabile, ma inevitabile, necessaria per rimettere in circolazione ciò che, a torto, si credeva fosse un possesso ormai consolidato, fissato nell’immobilità delle versioni canoniche. Questo ha reso ancor più problematico per me il tentativo di ritradurre un autore ormai da sempre classico come Paul Verlaine, emblema e vertice della poesia francese ottocentesca, un’operazione che ho percepito come un azzardo supremo.
La traduzione, che ritengo una continua decodifica mentale del lettore, incarna esattamente il movimento frastagliato del pensiero: procede per scatti, strappi, deviazioni e abbagli. È, in fondo, un’infedeltà divenuta legittima, un atto in cui ogni eco, ogni flebile somiglianza si fa immediatamente testo, suono. Così, sulle pagine prende forma una mappa della coscienza, idolo e demone insieme, entità primigenia di ogni tempo, sospesa tra il passato e un futuro che si plasma attraverso il linguaggio.
Questa non fu una traduzione, per me, ma una versione — parola che preferivo poiché non mi consideravo un traduttore —, una versione che mi sono autorizzato a realizzare e che vide la luce nel 1992 grazie a Giorgio Bertelli, raffinato editore de L’Obliquo di Brescia, che la pubblicò come una plaquette. Si trattava di un testo giovanile, amato da Rimbaud, che giudicavo di qualità sublime per resa e creatività, ma forse inascoltato, dimenticato per le orecchie contemporanee. Il mio obiettivo era riabilitarlo, renderlo di nuovo disponibile, in linea con la mia vocazione a una letteratura popolare e collettiva, già allora percepita come urgenza imprescindibile. Nel lavoro di Verlaine risuonava una visione democratica e tollerante, un sentire comunardo, un sapere che chiedeva di essere condiviso.
Nonostante sapessi fin dall’inizio che tradurre la parola di Verlaine sarebbe stato un gioco impossibile, proprio per questo esatto motivo decisi che l’impresa andava tentata. Ogni versione, sapevo, sarebbe stata inevitabilmente un gesto calato nella propria storia personale, e nel mio caso divenne anche un implicito commento critico, nato dal rapporto fisico, quasi di scontro, che ingaggiavo con l’autore. Non vedevo le traduzioni come un’agone tra interpretazioni concorrenti, ma come prove di stile autonome. E quella mia versione, frutto di uno specifico momento storico e culturale, fu alla fine considerata un piccolo evento. Piccolo, sì, ma significativo in un contesto vivace e ricettivo.
Ora, ripensandoci, dopo anni di oblio, ho voglia di riportare alla luce quel lavoro, con qualche lieve aggiustamento, ma con la stessa consapevolezza: non è e non pretende di essere una traduzione nel senso classico del termine. Anzi, già la nettezza di certe scelte lessicali rivela una posizione ben precisa, una presa di posizione quasi programmatica. Il testo si snoda come un fiume verbale, un flusso sonoro in cui mi sono abbandonato, sospinto da un’immaginazione musicale fatta di voci impreviste, pause estatiche e ritorni inaspettati. Non mi interessava “far capire tutto”, ma piuttosto far percepire che ogni cosa umana, ogni moto dell’anima, possiede una sua dignità e bellezza, anche se fugace e sfuggente.
Rieseguendo la partitura di Verlaine, ho cercato di dotarla di un ventaglio lessicale talvolta inventato, talvolta alieno, per creare una sorta di extralingua personale, una deformazione gioiosa che si prendeva libertà con il ritmo, un continuo riordino che generava una peculiare estraneità rispetto all’originale. Non era la fedeltà al testo che mi interessava, ma la possibilità di suscitare nel lettore – anch’egli traduttore a suo modo, immaginatore folle – un’esperienza di libertà generata dal suono, prima ancora che dal significato.
Questo lungo inverno di ascolto di Melancholia culminò in un tentativo di reinvenzione, un atto di resistenza linguistica contro la standardizzazione del mercato editoriale. La mia traduzione è nata dal desiderio di esplorare il corpo fisico della parola, di cercarne un sapore teatrale, furfantesco, quasi un furto dei versi e delle cadenze. È un testo che vive di tensioni sottili, di un armamentario linguistico che oscilla tra il ricercato e il popolare, tra lo sferzante e il reticente, e che a tratti parodizza il sublime con un gusto per l’ironia e l’irrisione.
Nel rincorrere questo testo, ho voluto catturare la qualità incantatoria della parola, quella musicalità che si situa ben oltre il senso e che, come un flusso magico, rapisce il lettore precipitando la sua mente in un vortice fantastico. Così, rileggere Verlaine per me è stata un’esperienza caotica e ordinata allo stesso tempo, una danza tra abbandono e risveglio di connessioni impensabili.
In fondo, la mia traduzione è stata una celebrazione dell’inverno come metafora, un inno all’eroismo quotidiano, alle astuzie e alle cadute di un’umanità bonariamente sgangherata. Ho costruito reti di rimandi, ricorsi e riprese che davano l’impressione di un continuo rigenerarsi, oscillando tra il mondo individuale e quello collettivo, tra la mente e la realtà. Tutto ciò, per me, rappresentava una virtù trasformativa, un modo di riscrivere i testi, fedele al pensiero ma non alla parola, con energia, colori e tonalità proprie. E continua a essere, ancora oggi, una posizione insensata e personale, come ogni autentica posizione dovrebbe essere.
LE VERSIONI
Paul Verlaine
MELANCHOLIA
Edizioni l'Obliquo
Ozî 12
Dicembre 1992
I Saggi d’altritempi, che valgon quanto questi,
credettero, ed è un punto ancor dei più contesti,
leggere in cielo di fortune come di disastri
e che ogni anima legata fosse ad uno degli astri.
(S’è molto riso, non pensando che sovente
il ridere è ridicolo quanto il ridente,
di questo spiego sul mistero notturno.)
Ora coloro che son nati sotto il segno di Saturno,
selvaggio pianeta, caro ai negromanti,
hanno, fra tutti, secondo scrittura d’anni avanti,
buona parte di sfortuna e buna parte di bile.
L’immaginazione, inquieta e vulnerabile,
viene a render nullo, in loro, lo sforzo di Ragione.
Nelle loro vene, il sangue, sottile come velena pozione,
simile a lava brucia, e raro, scorre e scolla,
anticando il loro triste Ideale che si crolla.
Così da soffrire hanno i Saturniani e in modi tali
morire, ammettendo che siano mortali,
il loro piano di vita, in ogni linea si designa
per la logica d’una Influenza maligna.
_____
Rassegnazione
Da piccolo, andavo sognando Ko-Hinnor,
sontuosià persiana e papaple,
presenze eliogabale e sardanepale!
Il mio desìo creava sotto i tetti d’or,
tra i profumi, al suono di musiche,
harem senza fine, paradisèe fisiche!
Oggi, più calmo e non meno ardente,
ma sapendo la vita che ci fa piegare,
ho dovuto la mia bella follia refrenare,
rassegnandomi un bel niente.
Sia! Il grandioso scappa al mio dente,
ma, vergogna dell’amabile e vergogna del vile!
Odio per sempre la graziosa donna-monile,
la rima assonante e l’amico prudente.
____
Nevermore
Ricordo, ricordo, che vuoi da me? L’autunno
faceva volare il tordo attraverso l’aeraggio a-tono
e il sole dardava un raggio mono-tono
nel bosco ingiallendo ove il gelo de-tono.
Noi eravamo da solo a sola e camminavamo sognando,
lei ed io, i capelli e i pensieri al vento lasciando.
A me, improvviso, il suo sguardo voltando:
“quale fu il tuo più bel dì?” con voce dorata parlando,
la sua voce dolce e sonora, timbro angelico e fresco.
Discretamente risposi con un sorriso di pesco,
e le sue mani bianche baciai devotamente.
Ah! i primi fiori quanto sono profumati
e come risuona d’echi dolcemente
il primo sì che esce dai labbri amati!
____
Dopo tre anni
Avendo spinta la porta stretta che barcolla,
ho passeggiato nel piccolo giardino
schiarito dolcemente dal sole del mattino,
paiettante d’un’umida scintilla ogni corolla.
Niente è cambiato. Ho tutto riveduto: l’umile riparamento
di selvatico viticcio con le sedie di giunco…
Il getto d’acqua fa sempre il suo argentino mormorio
e il vecchio pioppo il suo sempreterno lamento.
Le rose come sempre palpitano; sempre ripetenti,
i grandi gigli orgogliosi si muovono ai venti.
Ogni allodola che va e viene m’è già sembrata.
Egualmente ho ritrovato in piedi la Valléda
ove il gesso si scaglia alla via cominciata
gracile, fra l’odore insipido di reseda.
____
Voto
Ah! intimi colloqui! Le prime amate!
L’oro dei capelli, l’azzurro d’occhi, di carni il fiore
e poi, fra l’odore dei corpi giovani e d’amore,
la spontaneità di carezze timorate!
Sono assai lontane tutte queste allegrezze
e tutti questi candori! ahimè! tutto verso
la primavera di rammarico si fugge il nero inverno riverso
della mia noia, dei miei disgusti, delle mie tristezze!
Ora eccomi solo, taciturno e solo,
mesto e disperato, più freddo d’un avolo,
e simile ad un povero senza sorella nella sua orfanezza.
Oh la danna dall’amore caliente e carezzante,
dolce, pensierosa e bruna, e mai in mentale arretratezza,
e che talvolta vi bacia in fronte, come un infante!
____
Stanchezza
A batallas de amor campo de pluma.
(Gongora)
Dolcezza, dolcezza, dolcezza!
Placa un po’ questi febbrili trasporti, mia fascinante.
Pure al colmo del piacimento, vedi, l’amante,
della sorella deve avere la pacifica rilassatezza.
Sii languida, rendi la tua carezza sonnale,
ben eguali i tuoi sospiri e il tuo tranquillo guardare.
Già, la stretta gelosa e l’ossessivo spasmare
non valgono un lungo bacio, pur mentale!
Mi dici, mia bimba, nel tuo caro cuore d’oro,
la selvaggia passione dà dell’olifante il sonoro!…
lasciala suonare a suo piacere, l’affamata!
Poni la tua fronte sulla mia e nelle mie le tue mani
e promettimi che scorderai domani,
e piangiamo fino a che sarà giorno, o piccola infuocata!
____
Il mio sogno familiare
Sovente faccio questo sogno strano e penetrante
d’una donna sconosciuta, e che amo ricambiato,
e che non è mai la stessa ad ogni reincontrato
sogno ma neppure altra, e mi comprende e m’è amante.
Poiché ella mi capisce, il mio cuore, trasparente
soltanto per lei, eh già!, cessa d’essere tremore
per lei, della mia allibita fronte il sudore
lei sola sa rinfrescare, piangente.
È bruna, bionda o rossa? Io l’ignoro.
Il suo nome? Mi ricordo che è dolce e sonoro
come quello degli amati che la vita scaccia.
Pari a quello delle statue è il suo sguardo,
e, lontana e calma, grave, la sua voce abbraccia
morte voci nel pieno del riguardo.
____
A una donna
A voi questi versi per la grazia consolante
dei vostri grandi occhi dove ride e piange un grande sogno,
per l’anima vostra pura e buona, a voi – senza bisogno –,
questi versi dalla mia disperazione affondante.
Ahimè, l’incubo schifoso che mi bazzica braccante
non ha tregua e va furioso, folle, geloso,
si moltiplica quale coorte di lupi – manto peloso –
e si lega alla mia sorte sanguinante!
Oh! soffro, soffro orribilmente affronto
e il primo gemere del primo uomo cacciato dal Paradiso,
non è che un’egloga al mio in confronto!
E le premure che voi avete fanno buon viso
a rondini su di un cielo nel mezzogiorno passato
cara! – da un bel giorno di settembre dolciato.
____
L’angoscia
Natura, niente di te mi commuove, né gli spanti
campi, né l’eco vermiglia dei pastorali
siciliani, né le magne aurorali,
né la solennità dolente dei calanti.
Io rido dell’Arte, rido pure dell’Uomo, dei cantabili,
dei versi, dei templi greci e delle torri a spirali
che slanciano nel cielo vuoto le cattedrali,
e vedo con lo stesso occhio buono e non amabili.
Non credo in Dio, abiuro e rinnego,
ogni pensamento, e in quanto al vecchio diniego,
l’Amore, vorrei che non più se n’andasse a dire.
Tedio di vivere, avente paura di morire, eguale
al vascello perduto nel gioco del fluire e rifluire
l’anima mia salpa per naufragi nel male.