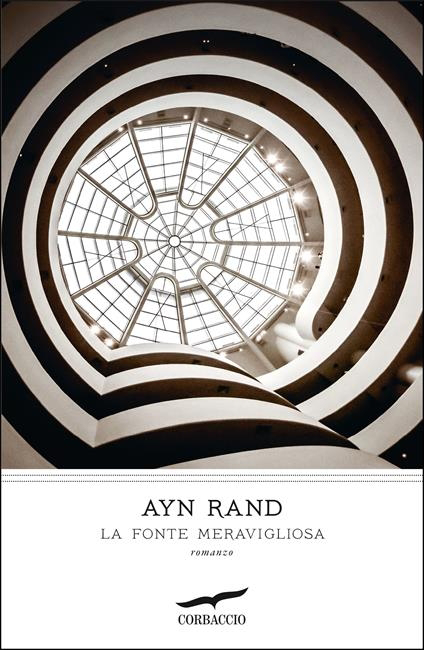Il 2 febbraio 1905, la nascita di Alissa Zinovievna, meglio conosciuta come Ayn Rand, a San Pietroburgo non è solo un semplice evento in una data lontana nel tempo, ma rappresenta un punto di partenza per una figura destinata a cambiare la filosofia, la letteratura e la politica nel corso del Novecento. San Pietroburgo, la città che la vide nascere, non era una città come tutte le altre: nel pieno della sua bellezza imperiale e culturale, era anche una città intrisa di tensioni politiche, in cui il fermento della modernità stava portando a una crisi che avrebbe avuto conseguenze enormi sul futuro del paese. Rand sarebbe stata testimone della fine di un'epoca e della nascita di un'altra, quella dell'impero sovietico, un mondo che avrebbe influenzato profondamente il suo pensiero e le sue future battaglie ideologiche.

La sua infanzia e giovinezza furono segnate dal crollo del sistema zarista e dall’ascesa del regime comunista, eventi che lasciarono un’impronta profonda nella sua visione del mondo. Cresciuta in una famiglia borghese, Rand osservò il crollo di quella stessa classe sociale sotto la pressione dei cambiamenti politici e sociali. La sua è stata un'infanzia da spettatrice, ma anche una formazione che le ha permesso di vedere il volto oppresso della società russa durante e dopo la Rivoluzione d'Ottobre. Le sue esperienze dirette della violenza politica, della collettivizzazione forzata e della crescente omologazione della società sovietica la portarono a sviluppare un profondo odio per qualsiasi forma di totalitarismo e collettivismo. Questa esperienza viscerale, unita alla sua straordinaria capacità di osservazione e riflessione, avrebbe forgiato le basi della sua filosofia.

Il suo rifiuto della realtà sovietica, in cui l’individualismo era messo a tacere e le libertà personali venivano annientate, non fu solo una reazione alla repressione, ma anche una risposta alla soffocante normalizzazione dei comportamenti e delle idee imposte dallo stato. Il collettivismo, per Rand, non era solo un sistema politico, ma un attacco all'individuo e alla sua capacità di ragionare e agire in modo autonomo. Per lei, ogni individuo aveva il diritto di perseguire la propria felicità senza l’interferenza di forze esterne che lo costringessero a piegarsi alle necessità collettive. Rand sosteneva che solo un mondo in cui gli individui fossero liberi di agire e pensare senza costrizioni sociali o politiche potesse garantire il progresso.

Nel 1926, Rand fece il passo che avrebbe cambiato la sua vita: emigrò negli Stati Uniti. Abbandonando la sua patria e la Russia rivoluzionaria, si trasferì a New York e poi a Los Angeles, dove trovò una città che le offriva nuove opportunità e spazi per pensare e scrivere, sebbene con una mentalità e un contesto sociale ben diversi da quelli che aveva conosciuto in Europa. Ad Hollywood, trovò un lavoro come sceneggiatrice e si avvicinò al mondo della scrittura, ma anche alla sua lotta interiore tra l'affermazione del sé individuale e il conformismo sociale, un conflitto che si rifletteva spesso nei suoi lavori. Negli Stati Uniti, Rand poté abbracciare il sogno di una nazione che rappresentava l'idea di una terra in cui la libertà individuale, l'iniziativa privata e il successo personale erano i principi su cui si fondava l’intero sistema sociale. Ma, proprio in quel mondo che aveva accolto così calorosamente gli immigrati, lei iniziò a sviluppare un’altra visione, che avrebbe dato vita alla sua filosofia distintiva: l'oggettivismo.

A Hollywood, dove iniziò a lavorare nel mondo del cinema, Rand poté vivere un tipo di esperienza che si distaccava dal rigido controllo sovietico. Ma il suo spirito ribelle non la faceva mai stare tranquilla, nemmeno in un paese come gli Stati Uniti che, a suo avviso, stava intraprendendo un cammino altrettanto pericoloso. Il capitale, il mercato libero e la competizione, sebbene facessero parte di una ideologia liberale, secondo lei, non erano abbastanza tutelati. A suo avviso, il governo degli Stati Uniti era già diventato troppo interventista, la burocrazia troppo opprimente e i principi di libertà economica troppo sottomessi al compromesso politico. La sua soluzione a questo problema fu una difesa radicale dell’individualismo e della libertà economica, e ciò che avrebbe definito come "capitalismo puro", senza l’interferenza di uno stato che potesse distorcere la libertà di scelta. Per Rand, la strada da percorrere era chiara: l’uomo doveva essere libero di compiere le proprie scelte, senza dipendere dalla benevolenza del governo o dall’opinione della massa.
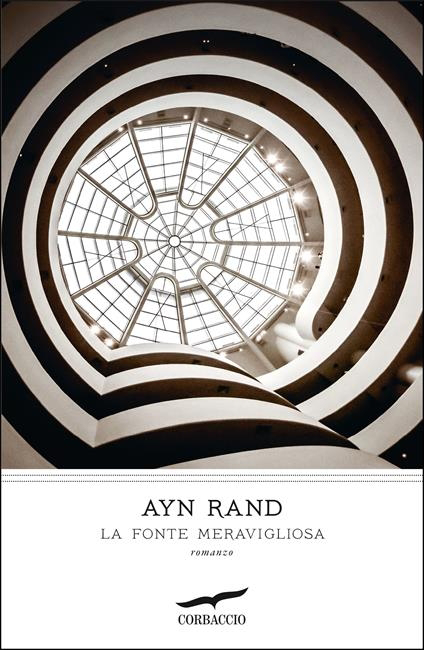
Nel 1943, pubblicò il suo primo grande romanzo,
La fonte meravigliosa (
The Fountainhead), un'opera che la consacrò al pubblico come una pensatrice controversa, ma anche come una delle scrittrici più innovative del suo tempo. La storia del protagonista, Howard Roark, un architetto che rifiuta di scendere a compromessi con una società che non comprende la sua visione artistica e architettonica, divenne un vero e proprio manifesto per il pensiero randiano. Roark, pur essendo un uomo solitario e in conflitto con le istituzioni sociali, incarna l’ideale randiano dell'individuo che lotta per la propria integrità e visione, contro le forze della mediocrità e del conformismo che caratterizzano la società collettivista.
Tuttavia, fu con il suo capolavoro successivo,
La rivolta di Atlante (
Atlas Shrugged), pubblicato nel 1957, che Rand raggiunse l'apice della sua carriera letteraria e filosofica. Questo romanzo non è semplicemente una narrazione, ma una riflessione amara e senza compromessi sulle contraddizioni e i pericoli del mondo moderno, dominato dall'intrusione dello stato nella vita privata e dai principi dell'uguaglianza a scapito delle reali possibilità di realizzazione dell’individuo. La trama, che ruota attorno a un misterioso e progressivo crollo delle istituzioni sociali ed economiche, metteva in evidenza una società che stava morendo a causa del parassitismo degli statali e dei burocrati, che si nutrivano della fatica e del genio degli altri. Protagonisti come Dagny Taggart e Hank Rearden sono l’incarnazione di un mondo in cui l’individuo, nel suo tentativo di perseguire il proprio successo e realizzare se stesso, è costretto a lottare contro l'immobilismo e la corruzione di una società incapace di premiare il merito.
Quello che distingue
La rivolta di Atlante dalle altre opere di denuncia sociale è la sua visione così radicale: Rand non si limitava a criticare la società, ma proponeva una soluzione altrettanto provocatoria: il ritiro, l'abbandono da parte degli uomini più capaci, quelli che creano e innovano, da una società che non era più in grado di apprezzarli. Una delle citazioni più potenti dell’opera, che ha fatto il giro del mondo, suona come una previsione inquietante di ciò che la società sarebbe diventata se non fosse stata in grado di apprezzare e incentivare l’ingegno e la libertà individuale:
"Quando ti renderai conto che, per produrre, devi chiedere il permesso a chi non produce nulla; quando vedrai che il denaro scorre verso chi non commercia beni, ma favori; quando scoprirai che la corruzione è premiata e l’onestà sacrificata, e che le leggi non ti proteggono, ma ti puniscono, allora saprai che la tua società è in declino."
Questa frase, scritta nel 1957, sembra descrivere la realtà del mondo moderno con una precisione sorprendente. Le disuguaglianze, l'immobilismo burocratico, il predominio degli interessi corporate sugli interessi pubblici sono solo alcune delle problematiche che Rand vedeva già come una minaccia per il futuro della civiltà. La sua denuncia, purtroppo, si è rivelata profetica.
Per tutta la vita, Rand si è battuta per le sue convinzioni, contestata da numerosi critici, che l’accusavano di egoismo e di ignorare i problemi sociali, come la povertà e la disuguaglianza. Tuttavia, la sua filosofia non è mai stata una giustificazione per l'indifferenza sociale, ma piuttosto un'invocazione alla responsabilità personale, all'importanza dell’integrità e della realizzazione dell'individuo. Il suo pensiero non ha mai rinnegato il bene collettivo, ma chiedeva che la collettività si fondasse sul libero arbitrio dell’individuo e sulla sua capacità di scegliere e agire liberamente.

Quando Ayn Rand morì nel 1982, lasciò un'eredità che continuò a dividersi tra gli ammiratori e i critici, ma le sue idee rimasero salde nel dibattito intellettuale. Oggi, a distanza di decenni dalla sua morte, il pensiero randiano continua a suscitare discussioni vivaci e polarizzate, e molte delle sue intuizioni sembrano essere ancora straordinariamente rilevanti per il mondo che viviamo. Con il suo invito alla difesa della libertà individuale, al rifiuto delle ideologie totalitarie e alla protezione dei diritti fondamentali, Ayn Rand ci lascia un’eredità di pensiero che, pur nella sua durezza e radicalità, continua a interrogare e ispirare.