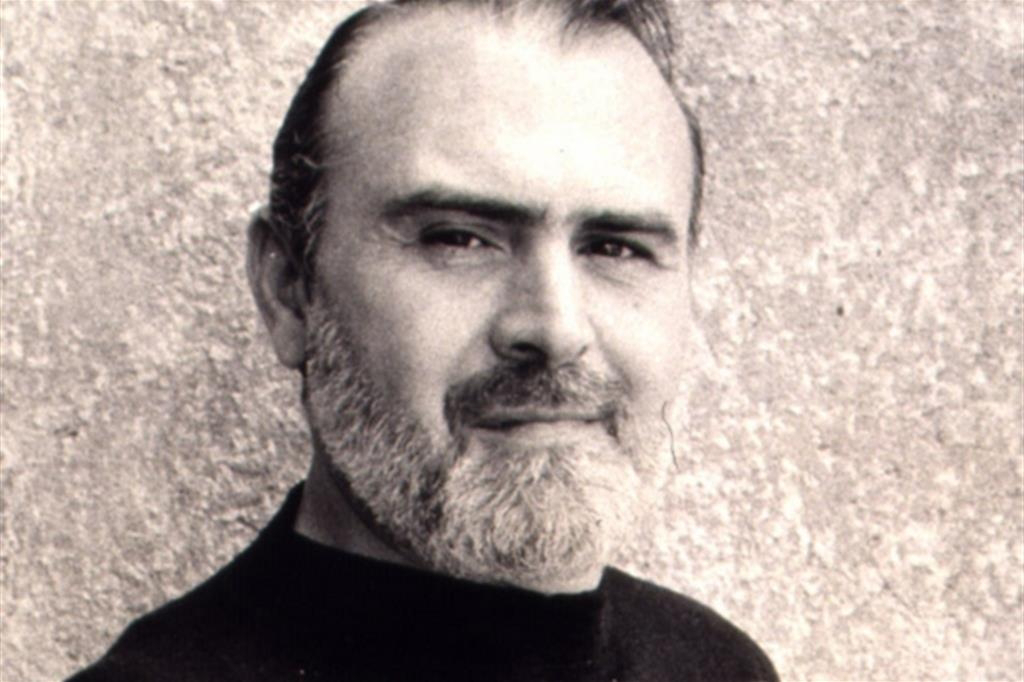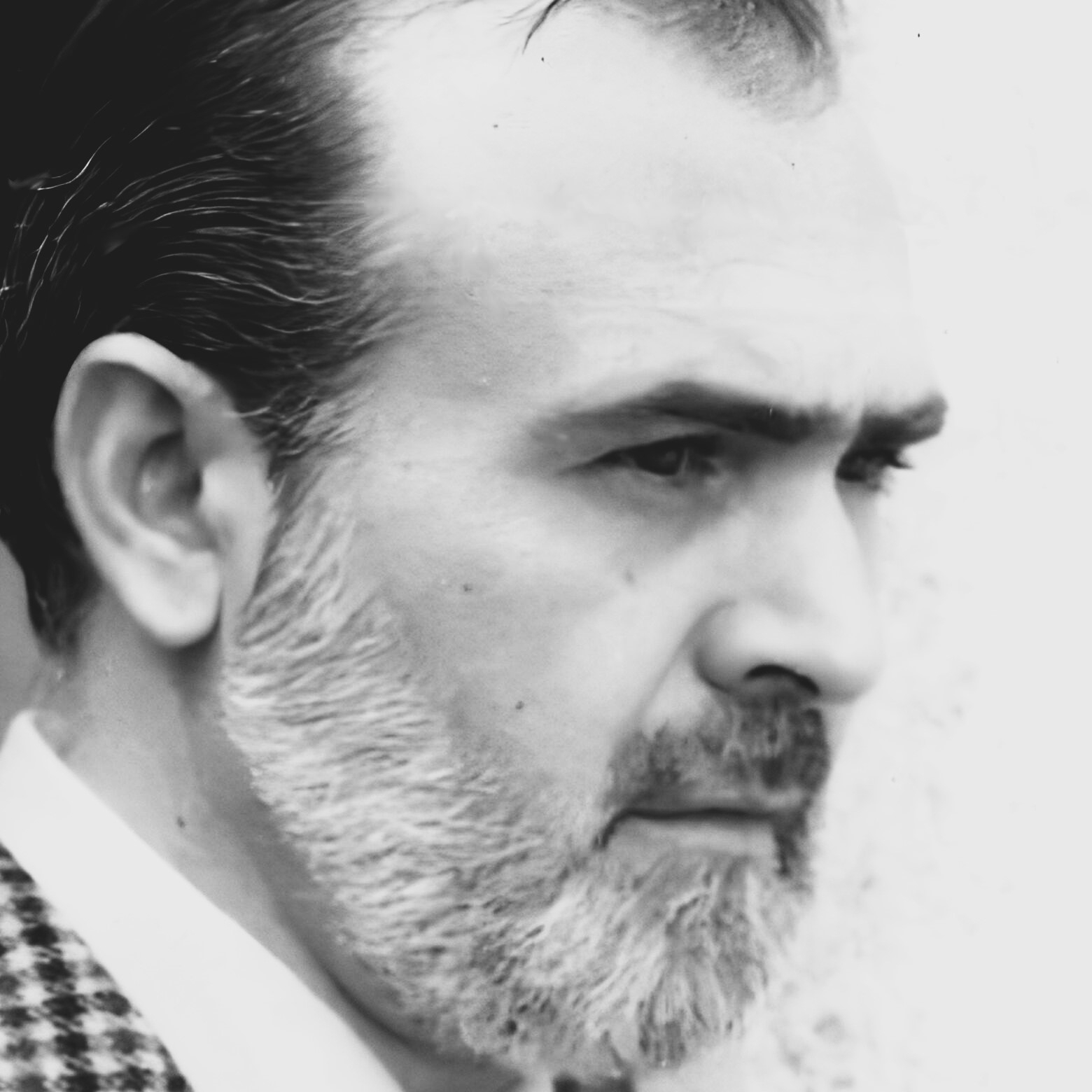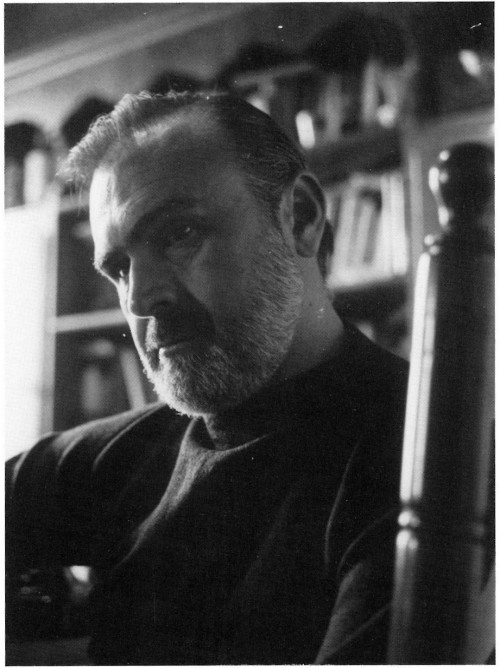Nel vasto e complesso panorama della poesia italiana del secondo Novecento, pochi libri hanno lasciato un segno così netto e incisivo come L’osso, l’anima di Bartolo Cattafi, pubblicato nel 1964 nella collana Lo Specchio di Mondadori sotto la direzione di Vittorio Sereni. Questa raccolta rappresenta il punto più alto della ricerca poetica di Cattafi, un autore che, pur non essendo mai stato al centro delle mode letterarie, ha saputo costruire un percorso originale e coerente, capace di resistere al tempo e di mantenere intatta la sua forza espressiva.
La sua poesia si colloca in una terra di confine, tra l’immediatezza del frammento e la densità simbolica della visione. È una scrittura che sfugge alle etichette, che non si lascia ingabbiare nelle categorie della poesia lirica o sperimentale, ma che al contrario si muove con estrema libertà tra la parola incisa e l’eco del non detto. In L’osso, l’anima, questa tensione tra visibile e invisibile, tra materia e spirito, tra certezza e enigma, raggiunge la sua massima espressione.
Questa raccolta si distingue per il suo carattere radicalmente essenziale, dove la parola poetica viene ridotta al suo nucleo più denso e significativo. Ogni componimento è una sorta di sentenza definitiva, un’incisione netta sulla pagina, un frammento che conserva intatta tutta la potenza di un’esperienza vissuta con assoluta lucidità. Cattafi, con L’osso, l’anima, raggiunge l’apice della sua ricerca espressiva, offrendo una poesia che è insieme concreta e rarefatta, scarnificata e vibrante, in grado di evocare, con la massima economia di mezzi, le tensioni profonde dell’esistenza.
Un titolo programmatico: tra materia e spirito
Il titolo L’osso, l’anima è già di per sé una dichiarazione di poetica. L’osso è ciò che resta dopo ogni consumazione, è la struttura, lo scheletro, l’elemento irriducibile. È la parte più dura, più resistente, quella che sopravvive all’erosione del tempo. L’anima, al contrario, è ciò che sfugge, il residuo impalpabile, la tensione verso qualcosa di inafferrabile, la dimensione più sottile e ineffabile dell’esistenza.È proprio tra questi due estremi che si muove la poesia di Cattafi: da un lato, il rigore geometrico della parola, l’attenzione all’essenzialità della forma; dall’altro, un’inquietudine sottesa, una vibrazione che attraversa il testo e lo rende sempre aperto a nuove interpretazioni. Non è un caso che il poeta abbia scelto un titolo così netto e binario, dove due elementi apparentemente opposti si trovano a coesistere in un equilibrio instabile, ma profondamente significativo.
Questo dualismo si riflette in ogni aspetto della raccolta. I versi di Cattafi sono brevi, taglienti, privi di orpelli. La sua poesia non indulge in descrizioni superflue, non si perde in divagazioni liriche, ma punta dritto al centro della percezione, lasciando emergere immagini di una nitidezza quasi brutale.
Tagliano il cielo / fili d’acciaio / tesi tra due pali.
Un’immagine semplice, ma che racchiude tutta l’essenza della sua scrittura: la tensione tra il concreto e l’astratto, la realtà ridotta a pochi elementi essenziali, ma carica di un’inquietudine sotterranea.
Il punto di svolta nella poetica di Cattafi
Prima di L’osso, l’anima, la poesia di Cattafi aveva avuto un andamento più disteso, spesso visionario, con una maggiore apertura alla narrazione. Si pensi a raccolte come Nel centro della mano (1951) e Le mosche del meriggio (1958), dove la sua scrittura, pur già segnata da un senso acuto della precarietà dell’esistenza, si permetteva ancora di espandersi in immagini più ampie e in una musicalità più articolata.Con L’osso, l’anima si assiste invece a una radicalizzazione del suo stile. Il linguaggio si contrae, il verso si fa scarno, la parola viene portata al suo limite. È un cambiamento che segna una maturazione decisiva, avvicinando Cattafi a certe soluzioni della poesia ermetica, ma senza mai perdere la sua specificità.
La sua lingua diventa più geometrica, più scarna, ma al tempo stesso incredibilmente evocativa. È come se il poeta avesse deciso di eliminare tutto ciò che è superfluo, lasciando soltanto l’essenza delle cose. Ogni componimento è un microcosmo perfetto, una struttura chiusa che però si apre a infinite risonanze.
L’occhio del poeta: la realtà vista attraverso una lente metafisica
Ciò che rende unica la poesia di Cattafi è il suo modo di guardare il mondo. Il suo sguardo è insieme preciso e straniante: le cose vengono osservate con un’attenzione quasi ossessiva, ma al tempo stesso vengono caricate di una valenza simbolica che le rende enigmatiche.Si pensi a questi versi:
Mi sveglio e sono ancora qui / nel punto dove il lampo mi ha lasciato.
Qui non c’è solo un senso di immobilità e di attesa, ma anche l’idea di un evento improvviso che ha lasciato un segno indelebile. Il "lampo" è un’immagine ambivalente: può essere la rivelazione, la presa di coscienza, ma anche la violenza del tempo che passa e lascia il soggetto fermo, inerme.
Questa capacità di trasformare il dettaglio più concreto in un elemento di vertigine avvicina Cattafi alla grande tradizione della poesia metafisica. Come Montale, è capace di partire da un oggetto quotidiano per aprire uno spazio di interrogazione esistenziale. Ma, a differenza di Montale, la sua poesia non si sviluppa attraverso il ragionamento o il commento: è pura visione, pura epifania.
Un libro che resta: l’eredità di "L’osso, l’anima"
A distanza di sessant’anni, L’osso, l’anima è ancora un libro vivo, capace di parlare ai lettori con la stessa intensità del primo giorno. La sua capacità di esprimere con estrema economia di mezzi la tensione tra il visibile e l’invisibile ne fa un’opera che continua a interrogare e a provocare.Cattafi, con questa raccolta, ha scritto una poesia che non indulge, che non ammicca, che non si disperde in nulla di superfluo. Ha inciso sulla pagina un pensiero che brucia e illumina, con la precisione di una lama.
E come tutte le opere che arrivano all’essenza delle cose, L’osso, l’anima non è solo un libro di poesia: è un libro di resistenza, un libro di sopravvivenza. Un libro che, come l’osso, resta.